N.B.: per leggere le Omelie di don Giancarlo cliccate sul triangolo a lato della voce di menu <Letture> e selezionate <Omelie di don Giancarlo Gambasin>.
Carla Bino, Dal trionfo al pianto
Louis De Wohl
Chiara Frugoni, Medioevo sul naso
Nikolaus Harnoncourt, Il discorso musicale
Ildegarda di Bingen, Lettera ai prelati di Mainz
Régine Pernoud, Luce del Medioevo
Joseph Ratzinger Liturgia e musica sacra
Oliver Sacks, Musicofilia
ILDEGARDA DI BINGEN, LETTERA AI PRELATI DI MAINZ
Di Ildegarda di Bingen abbiamo già parlato qui sotto nell’articolo “L’amore nel Medioevo”. Ora desidero proporre la lettura di una missiva che la santa inviò ai suoi superiori di Mainz per richiedere di ritirare l’interdetto che i prelati avevano imposto al suo monastero a causa delle esequie di un defunto. È tutto ben raccontato dal testo, che riprendo dalla versione pubblicata sempre nel libro della Fumagalli Beonio Brocchieri, In una aria diversa (Mondadori, non disponibile, pp. 165-171), del quale ho già proposto alcuni estratti nell’articolo sopra citato.
Voglio solo aggiungere alcune brevi riflessioni personali.
Dal testo di Ildegarda possiamo dedurre che l’interdetto fosse ingiusto, ma la badessa si guarda bene dal disobbedire ai superiori, rimanendo perfettamente in comunione con la Chiesa, una unità vissuta con grande sofferenza, come si può intuire, ma con altrettanto grandi fede e speranza. Sappiamo che la richiesta sortirà l’effetto sperato, perché l’interdetto sarà rimosso. Come ci sembra lontano da questa fede l’atteggiamento di molti ecclesiastici e sedicenti teologi, oggi, che per il prurito di strizzare l’occhio alla mentalità secolare dominante non si fanno scrupoli a contestare il magistero della Chiesa.
Infine, le riflessioni sulla musica e sulla sua origine sono ciò che di più bello e poetico si possa leggere. Tutti coloro che come noi amano e bramano la Bellezza non potranno rimanere insensibili alle parole della santa tedesca, là dove ci spiega il perché, all’ascolto della musica – quando questa è sincera espressione della ricerca della Verità – la commozione ci sale dal cuore agli occhi.
«Sono stata costretta a scrivere queste cose nella visione che Dio artefice ha infisso nella mia anima prima ancora che nascessi. Le scrivo a proposito dei vincoli impostici dai nostri maestri a causa di un defunto che abbiamo sepolto presso di noi invitate dal suo sacerdote e senza intenzione di inganno. Pochi giorni dopo la sua sepoltura, i nostri maestri ci ordinarono di gettarlo fuori dal cimitero. Io, presa da un grande timore, mi rivolsi al vero Lume, come sono solita fare, e, vigile, ad occhi aperti, vidi nella mia anima che se avessimo seguito quell'ordine il nostro monastero sarebbe stato minacciato da un gravissimo pericolo: un profondo buio, nero come quelle nubi scure che appaiono prima delle tempeste e dei temporali, ci avrebbe avvolto da ogni parte. Per questo non osammo gettar fuori dal cimitero il corpo di quel defunto: era stato confessato, comunicato e unto con l'olio sacro ed era stato sepolto senza contraddire le leggi della Chiesa. Non ci piegammo dunque al consiglio, o meglio all'ordine, di coloro che cercavano di convincerci, o ci comandavano di compiere quel gesto, non perché non tenessimo in nessun conto il suggerimento di uomini onesti, ossia dei nostri prelati, ma perché non sembrasse che noi con femminile malvagità ingiuriassimo i sacramenti del Cristo dai quali quell'uomo, quando era ancora in vita, era stato benedetto. Ma per obbedire almeno in parte agli ordini che ci erano stati dati, secondo l'interdetto, non abbiamo più cantato le lodi divine e ci siamo astenute dal partecipare all'Eucarestia, a cui eravamo solite accostarci all'incirca una volta al mese.
Tutto questo gettò me e le mie sorelle in una grande amarezza e un'immensa tristezza ci opprimeva. Schiacciata alla fine da tanto peso, udii nella visione queste parole: «Non è bene che voi per obbedire a parole umane abbandoniate i sacramenti del corpo del mio Verbo, vostra salvezza, che nacque da una natura vergine, dalla Vergine Maria. Ma dovete chiedere il permesso ai vostri prelati chi vi hanno imposto il divieto. Da quando Adamo fu scacciato dalla luminosa regione del Paradiso nell'esilio di questo mondo1, proprio a causa di quella prima colpa, ogni concepimento porta già in se la corruzione. Perciò fu necessario, secondo l'impenetrabile decisione di Dio, che dalla natura umana nascesse un uomo che non fosse stato contagiato in alcun modo dal peccato, attraverso cui tutti coloro che erano predestinati alla vita fossero purificati da ogni macchia e santificati attraverso la comunione con il suo corpo, affinché Egli rimanesse in loro, come questi in Lui, a sua difesa, sempre. Colui che, come Adamo, disobbedisce ai precetti divini e se ne dimentica completamente, deve rimanere separato dal corpo del Cristo, poiché con la sua disobbedienza si è allontanato da Lui, finché la penitenza lo avrà purificato e i maestri gli avranno concesso di partecipare di nuovo all'Eucarestia. Colui che invece si sarà reso conto di subire tale divieto senza essersene reso consapevolmente e volontariamente colpevole, si può accostare senza timore a ricevere il sacramento vivificante, per essere mondato dal sangue dell'Agnello immacolato, che, obbediente al Padre, si lasciò immolare sull'ara della croce per ridare a tutti la salvezza».
Sempre nella stessa visione udii che ero colpevole per non essermi presentata in tutta umiltà e devozione davanti ai miei maestri, a chiedere loro il permesso di accostarmi all'Eucarestia, soprattutto dal momento che non ci eravamo macchiate di nessuna colpa per avere accettato quel defunto, fortificato dal suo sacerdote con ogni sacramento e sepolto con la processione di tutto il monastero senza andare in alcun modo contro la legge. Dio mi impone di annunziare a voi, signori e prelati, queste cose.
Nella visione vidi anche qualcosa a proposito del fatto che obbedendo a voi abbiamo smesso di cantare gli uffici divini e li celebriamo soltanto a bassa voce, e udii una voce che procedeva dalla Luce vivente a proposito dei diversi generi di lode, dei quali Davide dice nel salmo: «Lodatelo con suoni di trombe, lodatelo con salteri e cetre... Ogni spirito lodi il Signore»2. In queste parole aspetti esteriori ci insegnano verità che riguardano la realtà interiore: la struttura materiale degli strumenti e le loro diverse qualità musicali ci dicono come dobbiamo finalizzare le azioni del nostro essere interiore per volgerle soprattutto a lode del Creatore. Se ci applichiamo a queste arti con diligenza possiamo recuperare il modo in cui l'uomo cercò la voce dello Spirito vivente, che Adamo aveva perso con la sua disobbedienza.
Prima della trasgressione, infatti, quando era ancora innocente, Adamo aveva in comune con gli angeli la voce per cantare le lodi: questi la possiedono per la loro stessa natura spirituale, che prende il suo nome dallo stesso Spirito divino. Adamo perse quest'affinità con le voci angeliche che aveva nel Paradiso quando si fece ingannare dal diavolo, opponendosi per consiglio di questi alla volontà del suo Creatore. Per colpa della sua iniquità, fu avvolto allora dalle tenebre dell'ignoranza interiore: fu come se avesse dormito profondamente per tutto il tempo in cui aveva posseduto la scienza e ora, svegliandosi, fosse dubbioso e insicuro delle cose che aveva visto nei sogni. Ma Dio, che con la luce della verità riserva le anime degli eletti alla primitiva beatitudine, aveva già deciso di rinnovare di quando in quando con l'infusione dello spirito profetico molti cuori, quanti più poteva: questo avrebbe in parte sopperito alla mancanza di quella illuminazione interiore, che Adamo possedeva prima di essere giustamente punito per la sua trasgressione. I santi profeti, ammaestrati dallo stesso Spirito dal quale erano ispirati, composero non soltanto salmi e canti, da cantarsi per accendere la devozione nei fedeli, ma inventarono anche diversi strumenti musicali per arricchire i canti con suoni variati e ciò affinché gli uomini si rammentassero della dolce lode della quale Adamo prima della caduta gioiva in Dio insieme con gli angeli, invece che del suo esilio, e anche per invitare l'umanità a questa dolce lode. Questo lo fecero in modo che gli stessi ascoltatori sollecitati e allenati, come abbiamo già detto, da aspetti esteriori (dalle forme e dalle qualità musicali degli stessi strumenti, come anche dal significato delle parole che venivano recitate) fossero istruiti su realtà interiori. Uomini volenterosi e sapienti, imitando i santi profeti, con arte umana inventarono alcuni generi di melodie per poter cantare secondo il piacere dell'anima e adattarono i loro canti ai movimenti delle dita, come ricordandosi che Adamo, nella cui voce prima del peccato c'era il suono di ogni armonia e la dolcezza di tutta l'arte della musica, fu formato dal dito di Dio, ossia dallo Spirito Santo. In quello stato originario egli possedeva una voce cosi forte e sonora, che la fragilità umana non potrebbe in alcun modo sopportare. Ma quando il diavolo ingannatore udì che l'uomo aveva cominciato a cantare per ispirazione di Dio stesso e capì che attraverso quest'arte si sarebbe trasformato sino a recuperare la dolcezza dei canti della patria celeste, vide vanificarsi le macchinazioni della sua astuzia e ne fu cosi spaventato da tormentarsi non poco: da allora sempre la sua malvagità si sforza di escogitare e di trovare nuovi stratagemmi. Così non smette mai di turbare o distruggere l'insegnamento e la bellezza delle lodi divine e degli inni spirituali agendo non solo sul cuore dell'uomo con suggestioni malvagie, pensieri immondi o occupazioni che lo distraggono, ma anche sul cuore della Chiesa, dovunque può, attraverso dissensi, scandali e ingiuste oppressioni. Per questo, voi e tutti i prelati, dovete stare sempre ben attenti prima di chiudere con un decreto la bocca ai cori che cantano lodi a Dio, o di proibire di venire a contatto con i sacramenti o dal riceverli: dovete discuterne, analizzando prima con molta cura le cause per cui questo deve essere fatto. Dovete guardare se a muovervi a questo è lo zelo per la giustizia o invece l'indignazione o un ingiusto moto dell'animo, o il desiderio di vendetta, e dovete stare sempre attenti a non essere raggirati da Satana, che trasse l'uomo dall'armonia celeste e dalle dolcezze del paradiso. Ponderate tutto con cura, poiché come il corpo di Gesù Cristo nacque per mezzo dello Spirito Santo dalla verginità di Maria, così anche il canto di lode, che segue l'armonia celeste, è radicato attraverso lo Spirito Santo nella Chiesa. Il corpo in verità è il vestito dell'anima, che ha una viva voce, e perciò è giusto che il corpo attraverso la voce canti con l'anima lodi a Dio. Per questo anche lo spirito profetico attraverso le sue significative parole ci ordina di lodare Dio con cembali di giubilo e con altri strumenti musicali3, che furono inventati da uomini sapienti e volenterosi. E dal momento che tutte le arti utili o necessarie all'uomo, sono state inventate dal soffio di vita che Dio immise nel corpo dell'uomo4, e giusto che in tutte si lodi Dio. E poiché talvolta gli uomini, ascoltando un canto sospirano e gemono, come rammentandosi la natura della celeste armonia dell'anima, il profeta considerando e comprendendo la natura sinfonica dell'anima, esorta nel salmo a dimostrare la nostra fede in Dio con la cetra, e a cantare a Lui sul salterio a dieci corde5, stabilendo un'analogia fra il suono grave della cetra e la disciplina del corpo, fra il suono acuto del salterio e l'intenzione dello spirito, fra le dieci corde e l’obbedienza al Decalogo.
Coloro perciò che, senza ragioni sicure, impongono il silenzio ad un'assemblea nei canti di lode a Dio, se non si saranno purificati per mezzo di una vera penitenza e di un'umile richiesta di perdono, in cielo saranno privati della partecipazione alle lodi degli angeli, poiché in terra spogliarono ingiustamente Dio dell'ornamento della sua lode. Coloro perciò che tengono le chiavi dei cielo stiano davvero attenti a non aprire ciò che deve essere chiuso e a chiudere ciò che deve essere aperto, poiché un giudizio durissimo cadrà su coloro che hanno il governo se, come dice l'Apostolo, non presiederanno con diligenza6. E udii una voce dai cielo che diceva: «Chi creò il cielo? Dio. Chi aprì il cielo ai suoi fedeli? Dio. Chi è simile a Lui? Nessuno».
Perciò, o fedeli, nessuno di voi opponga resistenza o sia contrario, affinché il giudizio divino non cada sopra di voi con la sua forza, senza che possiate avere alcuno che vi possa aiutare e difendere. Questo è un tempo effeminato, poiché la giustizia di Dio è debole. Ma la forza della giustizia di Dio riemerge comunque e si leva, come vergine guerriera, a combattere contro l'ingiustizia fino a che questa cadrà vinta.»
1 Gn 3,23.
2 Sa1 150, 3-5.
3 ivi.
4 Gn2,7.
5 Sa1 32, 2 o Sal 91, 4.
6 Rm 12, 8.
CHIARA FRUGONI, MEDIOEVO SUL NASO
Durante l’ultima “gita” in libreria mi sono imbattuto in un libro di Chiara Frugoni, uno dei maggiori medievisti italiani, intitolato Medioevo sul naso – occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali, Laterza, (ISBN 978-88-420-7356-7) La premessa – che cito parzialmente – è stata determinante per l’acquisto.
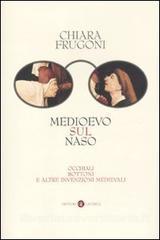
"Cosa dobbiamo al Medioevo? Provo ad enumerare alcune voci: gli occhiali, la carta, la filigrana, il libro, la stampa a caratteri mobili, l'università, i numeri arabi, lo zero, la data dalla nascita di Cristo, banche, notai e Monti di pietà, l'albero genealogico, il nome delle note musicali e la scala musicale.
Il Medioevo ci dà i bottoni, le mutande e i pantaloni; ci fa divertire con le carte da gioco, i tarocchi, gli scacchi e il carnevale; lenisce il dolore con l'anestesia, ci illude con gli amuleti (ma il corallo, che protegge i bambini e dal fulmine, aiuta anche a sgranare il rosario). Ha portato nella casa il gatto, i vetri alle finestre e il camino; ci fa sedere a tavola (i Romani mangiavano sdraiati) e mangiare, con la forchetta, la pasta tanto amata, proprio i maccheroni e i vermicelli, la cui farina viene instancabilmente macinata dai mulini ad acqua e a vento.
Ha saputo sfruttare la forza motrice dell'acqua mettendo in moto frantoi e segherie, gualchiere per panni, mulini da carta e da farina. Ha scoperto un'altra straordinaria forza motrice: il cavallo, che ha dotato di ferri ai piedi, di staffa, e di collare rigido, perché l'animale possa tirare senza essere soffocato dal peso; ha alleviato la fatica umana con la carriola, reso più sicuro il cammino dei naviganti con la bussola e il timone. In battaglia ha fatto sventolare le bandiere con gli stemmi colorati e risuonare il fragore della polvere da sparo, dei fucili e dei cannoni. Ha cambiato il nostro senso del tempo, su questa terra, con l'orologio a scappamento, introducendo le ore di lunghezza uguale e non più dipendenti dalle stagioni; ha cambiato il nostro senso del tempo, nell'aldilà, perché ha fatto emergere un terzo regno, il purgatorio, che rompe i destini immutabili dell'eternità. Infine, fa sognare i bambini con Babbo Natale."
(Franco)
Innamorarsi di Louis de Wohl è semplice come leggere un libro, e quando si arriva all’ultima pagina resta la nostalgia come di chi ha vissuto un’esperienza unica. I personaggi rimangono nella memoria come se si fossero davvero incontrati, conosciuti, ammirati, amati e odiati, a volte li si confonde con qualche amico che ormai non c’è più. Poi ci sono i paesaggi, descritti come in nessun dipinto, i dialoghi riportati come in nessuna sceneggiatura, e infine la Storia degli uomini, la vera protagonista, riportata come in nessun trattato storico. I libri di de Wohl sono degli incontri che lasciano il segno e fan desiderare di essere uomini migliori. Per questo val la pena di leggerli tutti, e sono tanti, e quando se ne scopre uno ancora non letto si corre a comprarlo.
Louis de Wohl nacque nel 1903, fu tedesco di padre ungherese e madre austriaca; durante la Seconda Guerra Mondiale fuggì in Gran Bretagna e divenne capitano dell’esercito britannico, poi visse in Svizzera, dove morì nel 1961. I suoi romanzi e biografie sono stati tradotti in numerose lingue, in Italia è pubblicato dalla BUR (fra l’altro con ottime traduzioni, fra tutte quelle del grande Ervino Pocar).
Se dovessi qui dire quale mi è piaciuto di più farei fatica, così ve ne segnalo alcuni, in ordine cronologico, non di scrittura, ma di periodo storico trattato.
-
Il primo è L’albero della vita, la storia di Costantino (quest’anno ricorre l’anniversario del suo Editto di Milano, nel 313, con cui si poté dare il via alla cristianizzazione dell’Europa), ma la vera protagonista è la madre, Sant’Elena, un vero gigante della storia cristiana, tutta da gustare la narrazione del ritrovamento della Croce di Cristo in Terrasanta.
-
Segue Attila. La tempesta dall’Oriente, il secolo è il V, la storia del grande condottiero unno che si intreccia con i fatti che preludiano al disfacimento dell’Impero Romano d’Occidente. Al centro il famoso incontro con Papa Leone che riuscirà a fermare il Flagellum Dei.
-
La Città di Dio. Storia di san Benedetto narra la nascita dell’ordine benedettino (secolo VI); sullo sfondo le vicende di Teodorico, re degli Ostrogoti e di Italia, e la città di Roma, ormai in rovina, sulla quale si staglia il grande filosofo e statista cristiano Boezio.
-
La librazione del Gigante, gli anni del violento attrito fra impero e papato, fra l’imperatore Federico II e Innocenzo IV, è il secolo XIII e san Tommaso d’Aquino saprà spiegare al mondo che la Fede cristiana non è in contrasto con la Ragione umana.
-
La mia natura è il fuoco. Vita di Caterina da Siena, la piccola santa degli ultimi, degli appestati, ma anche il grande dottore della Chiesa (lei che si dice non sapesse né leggere né scrivere) che riuscirà a convincere papa Gregorio XI a lasciare Avignone e ritornare nella città di Roma, unica sede del papato.
-
L’ultimo crociato. Il ragazzo che vinse a Lepanto. Storia di don Giovanni d’Austria, figlio illegittimo dell’imperatore Carlo V e fratellastro di Filippo II re di Spagna che comandò la flotta della Lega Santa nella celebre battaglia di Lepanto, nel 1571, con la quale inflisse una sconfitta importantissima per il futuro stesso dell’Europa e della Cristianità alla flotta dei Turchi Ottomani.
Non sfuggirà il dato che de Wohl, che visse gli anni più drammatici del sec. XX – fra cui quelli maledetti del Nazismo – abbia preferito raccontare fatti e personaggi di secoli che vanno dal IV al XVI. E non è finita: è del 2013 l’uscita, sempre per la BUR, di Il gioioso mendicante. Vita di Francesco d’Assisi. Quale migliore iniziativa editoriale per noi del Kalòs?
SL
CARLA BINO, Dal trionfo al pianto, La fondazione del “teatro della misericordia” nel Medioevo (V-XIII secolo), Vita e Pensiero, Milano, 2008
Quando guardiamo la Croce o una scena della Passione, quando cerchiamo di immedesimarci nel dolore della Vergine sotto il patibolo del Figlio, o nei pensieri tormentati di Giovanni, avvertiamo dei sentimenti che possono essere di tristezza e di angoscia; ma non ci rendiamo conto che queste suggestioni sono frutto di duemila anni di storia di fede cristiana che ha visto diversi modi di vivere e di approcciare l’imago della morte del Signore. La stessa icona del supplizio, la Croce, ha avuto un’evoluzione che l’ha portata attraverso i secoli ad essere segno di trionfo e vittoria sotto Costantino (in hoc signo vinces), di mistero nell’epoca carolingia – per la duplice natura umana e divina del Cristo – fino al fiorire della “drammaturgia delle lacrime”, la letteratura laudistica duecentesca, nata dal planctus, rappresentazioni di realismo anti-spettacolare, perché intese come ri-presentazioni del sacrificio di Dio.
“Da subito avevo notato che le laude, così come le preghiere, le meditazioni e gli uffici previsti per il tempo quaresimale e ancor più per la settimana santa erano incentrati su due elementi irrinunciabili (che ritornavano anche nella coeva raffigurazione artistica, pittorica e scultorea), ossia la puntuale e realistica descrizione delle violenze perpetrate su Cristo e il pianto inconsolabile di sua Madre. Questi due aspetti si univano in una drammaturgia che ricostruiva il percorso della passione attraverso gli occhi di Maria e da questa prospettiva restituiva l’immagine della carne piagata del Figlio, la quale, oltre che vista, era sentita come dolorosa. Davanti a questo nuovo racconto che veniva ‘agito’ in modi diversi, cantato in privato durante la flagellazione comune o in pubblico al venerdì santo o, più tardi, messo in scena con attori e costumi, i fedeli dovevano provare un sentimento di profondo coinvolgimento emotivo e un senso di partecipazione così forte – quasi fisicamente esperito – da essere turbati e contemporaneamente indotti a una risposta concreta di compassione. Non era una cerimonia liturgica e non era uno spettacolo: si trattava di una drammaturgia della pietà per un teatro della misericordia che rendeva presente qui e ora il ricordo di quello che era accaduto rendendolo accessibile, trasformandolo in un’esperienza”.
L’autrice conduce il lettore attraverso la letteratura, l’iconografia e lo studio dei testi liturgici nell’evoluzione storica di questo “sguardo”. Sullo sfondo della narrazione le lotte per l’iconoclastia e il dilagare di eresie (arianesimo, monofisitismo, nestorianesimo, adozionismo…) che a noi uomini del ventunesimo secolo appaiono questioni di lana caprina, se va bene, o al peggio il frutto del buio dell’intelligenza tutta medievale alla quale i libri di storia ci hanno abituato, ma che per il pensiero dell’uomo di allora volevano semplicemente dire lotta fra il Bene e il Male, fra la Vita e la Morte, fra Dio e Satana.
Il libro traccia un filo fra i testi che hanno segnato, condotto, a volte corretto, il sentire la Croce non come un’immagine sacra qualsiasi, che ricostruisce nella mente del fedele una persona o una storia, bensì come oggetto sacro, davanti al quale ci si prostra e si prega “vedendo e facendo memoria del corpo di Cristo piagato, ricordando la passione, imitando la sua umiltà, per ottenere la salvezza.”
Alcuni degli autori dei testi che hanno “costruito” nel corso dei secoli questa fede indirizzando il pensiero della Chiesa, e che l’autrice nella prima parte del libro sapientemente cita e incrocia, sono Alcuino, Rabano Mauro, Amalario di Metz, Candido di Fulda, Pascasio Radberto, uomini che hanno vissuto negli ultimi secoli del primo millennio, e che con la loro opera hanno contribuito anche alla costruzione della liturgia, sia per quanto riguarda i riti della Settimana Santa, sia per quello che è il drama per eccellenza, l’Eucarestia, il luogo nel quale si rivive – e non tanto si ricorda – il sacrificio di Cristo.
Molto bella e commovente risulta al lettore la ricostruzione dei riti del Venerdì santo (adoratio e depositio crucis, e nel giorno di Parasceve la visitatio), che nei testi liturgici del sec. XI sono così tanto dettagliati da avvicinarsi ad essere vere e proprie “disposizioni sceniche” di una rappresentazione che vede fedeli e clero partecipare con corpo, voce e mente al supplizio di Dio.
Seguendo lo sviluppo del pensiero cristiano, Pier Damiani (XI sec.) nei suoi testi esprime il desiderio di condividere la sofferenza di Gesù con la postura del corpo (prostrazione) e il pianto, spostando l’attenzione del fedele dalla sequela Christi alla imitatio Christi; ed è con Anselmo d’Aosta che si impone la confidenza nella misericordia di Dio, la “perfetta carità”, che si fa nostalgia, un aspetto emotivo inedito nella contemplazione del Crocifisso: dal dolore nasce l’amore. Nei testi di Sant’Anselmo si avverte il dispiacere di non essere stato lì, sul Golgota, l’anima allora riattiva quei momenti nella memoria sino ad essere presente sotto la Croce, e vede Maria, il suo volto angosciato, rigato dalle lacrime, e desidera sentire ciò che Maria sente; il pianto è il tema conduttore della preghiera di Anselmo, ed è con lui che si comincia ad imporre il culto mariano: Nihil aequale Mariae / nihil, nisi Deus, major Mariae (nessuno è pari a Maria, nessuno, se non Dio, è superiore a Maria).
Questo atteggiamento “emozionale” sfocia nel sec. XII in una amplificazione dello stesso concetto di affectus sia nei testi sacri (su tutti san Bernardo è il suo commento al Cantico dei Cantici) che laici, basti pensare alla poesia amorosa dei trovatori o ai racconti su Tristano e Isotta, o ai romanzi di Chrétien de Troyes, alle vicende di Abelardo ed Eloisa e infine all’amore che si appaga del non possesso del principe e trovatore Jaufre Rudel.
Con Ruperto di Deutz, nel suo commento al Vangelo di Giovanni alla fine del sec. XII, si sviluppa il tema della Madre che sotto la Croce prova gli spasimi delle doglie, partorendo la nuova umanità sanata dal sangue di Cristo; questa sembra essere la fonte iconografica dello svenimento di Maria.
L’autrice passa in rassegna, poi, alcune Passioni, di cui ci sono rimasti i testi, anche se solo frammentari. È il caso della Passione di Montecassino (ultimi decenni del sec. XII), e dei due Ludi de Passione Domini del codice di Benediktbeuern (circa 1230 ma il materiale raccolto risale all’XI sec., è la stessa silloge dei celebri Carmina Burana).
In questi componimenti si assiste a un cambio di prospettiva fondamentale: se i drammi liturgici proponevano una ri-presentazione della Passione, non tanto riattuandone la memoria, ma agendoli, presentandola cioè ai fedeli come realtà fattuale e viva, nei drammi di passione si passa a una rappresentazione scenica vera e propria. Ma la Bino ci precisa che non si può parlare di evoluzione, in quanto la loro funzione è diversa rispetto alle cerimonie liturgiche.
Il percorso della Bino si conclude nel secolo di Francesco, il Duecento. Nel pensiero francescano la Croce non è isolata all’interno della vita di Gesù, ma riassume in se stessa anche la gloria della resurrezione, restituendo così pienamente il senso positivo del dolore. “La croce e il crocefisso dicono la realtà più profonda di Dio e dell’uomo [...] l’autosvuotamento della divinità che si fa uomo e muore nel dolore diviene epifania d’amore e modello di imitazione”. Il crocefisso, allora, è un uomo sofferente, martoriato, piagato, il francescanesimo inaugura una “terza via” ripresentativa, differente dalla liturgia e dal dramma sacro del tempo, nella quale “rappresentare significa fare esperienza in prima persona e non solo assistere [...] il fatto non è solo presentato e agito qui e ora, né è solo partecipato affettivamente sino alla condivisione parentale. Ora subentra il principio mimetico dell’imitatio a sostanziare la verità di un ‘come se’ che non è finzione ma è sequela”.
Luoghi principali di questa devozione sono le confraternite dei disciplinanti, dove attraverso il canto delle laudi – sia esse narrative e dialogiche – si riviveva il mistero della passione di Cristo con un’intensità tale da rendere anche la flagellazione, personale e pubblica, una pratica non di pochi esaltati, come ci viene troppo facilmente da affermare ai giorni nostri, ma un gesto allo stesso tempo di penitenza e di amore, un atto di “imitazione e stimolo a vivere il ricordo. In tal modo la memoria è ri-presentata concretamente in una forma che è fisica ed esteriore e non più mentale e interiore”. E proprio a partire da questa drammaturgia del coro confraternale prende avvio il vasto capitolo del teatro della misericordia, del quale l’autrice, in chiusura del volume, riporta qualche (troppo) breve citazione.
SL
RÉGINE PERNOUD, Luce del Medioevo, Gribaudi Editore, Milano, 2000.
Copio dalla 4° di copertina: Il Medioevo epoca di tenebre. Tale è l'immagine che conosciamo rispetto a questo periodo storico. Régine Pernoud smentisce questo pregiudizio rivelando il Medioevo in tutta la sua luce. "Un mondo che aveva visto il lirismo, sbocciare la letteratura romanzesca e innalzare le cattedrali di Chartres e di Reims"
L'autrice, storica esperta del Medioevo, morta nel 1998, scrisse nel 1944 questo libro, primo di una serie di fortunati volumi dedicati alle figure più importanti della storia medievale, da Eloisa e Abelardo a Eleonora d'Aquitania, da Giovanna d'Arco a Cristina da Pizzano. Il metodo era semplice: raccontare i fatti non basandosi sui libri di storia già (spesso malamente) scritti, ma esclusivamente sui documenti originali dell'epoca, potendolo fare, infatti, visto che era conservatore presso il Musée des Archives Nationales di Francia.
Il libro racconta com'era la società medievale seguendo un itinerario che è poi quello dell'indice: L'organizzazione sociale, Il vincolo feudale, La vita rurale, La vita urbana, La monarchia, I rapporti con la Chiesa, L'insegnamento, Le lettere, Le arti, Le scienze, La vita quotidiana, La mentalità medievale.
Non mi voglio dilungare con una mia personale recensione (non ne sarei capace), ma solo proporvi alcuni estratti che nella lettura mi hanno parecchio suggestionato. La casa editrice del libro in italiano non me ne vorrà, per la lunghezza delle citazioni al limite del consentito, perché il mio consiglio è di comprare il libro e di leggerlo tutto (sempre che riusciate a trovarlo...).
L'organizzazione sociale
[...] Per capire veramente la società medievale bisogna studiare l'organizzazione della famiglia: è questa la "chiave" del Medioevo, ed è la sua caratteristica più originale. È un'epoca in cui tutti i rapporti si rifanno al modello familiare; quelli del feudatario con il suo vassallo, o quelli dell'artigiano con il suo apprendista. La vita dei campi, la storia della nostra terra si spiega soltanto con l'ordinamento delle famiglie che vi sono vissute. L'importanza di un paese si valutava dal numero dei "focolari" e non dall'ammontare della popolazione. Nelle leggi e nei costumi, ogni disposizione è rivolta al bene della famiglia o all'interesse della casata, oppure, ampliando tale concetto di famiglia ad una cerchia più vasta, all'interesse del gruppo o della corporazione, la quale non è che una famiglia più grande, basata sul medesimo modello del nucleo familiare propriamente detto. I grandi baroni sono anzitutto dei padri di famiglia, che raccolgono intorno a sé tutti coloro che, per nascita, fanno parte del patrimonio feudale; le loro contese sono principalmente lotte familiari, alle quali partecipa tutta la mesnie, che essi hanno il dovere di difendere e di amministrare. [...] (p. 22)
Il vincolo feudale
[...] la natura dei mutui rapporti che uniscono il proprietario ai suoi coloni variava secondo le circostanze, la natura del terreno e il modo di vivere degli abitanti; fattori di ogni genere entrano in gioco differenziando da una provincia all'altra, e anche da un feudo all'altro, i rapporti e le gerarchie; ma ciò che rimane costante è la reciproca obbligazione: fedeltà da una parte, protezione dall'altra, altrimenti detta: vincolo feudale. [...] (pp. 38-39)
La vita urbana
[...]Non si potrebbe definire meglio la corporazione medioevale che vedendo in essa l'organizzazione familiare applicata al mestiere. Essa raggruppa in un unico organismo tutti gli elementi di un certo mestiere: padroni, operai e apprendisti sono riuniti, non sotto un'autorità, ma grazie a quella solidarietà che nasce naturalmente dall'esercizio di una medesima professione. [...] La corporazione medievale è un corpo libero e le uniche leggi che conosce sono quelle che essa stessa si è data: è questo il suo carattere essenziale e lo conserverà sino alla fine del XV secolo. (p 65)
[...]
In conclusione, non si potrebbe meglio riassumere il carattere della vita cittadina del Medioevo che citando il grande storico delle città medievali, Henri Pirenne: "L'economia urbana [...] ha creato completamente [...] una legislatura sociale più perfetta di quella di ogni altra epoca, compresa la nostra. Sopprimendo gli intermediari tra il venditore e l'acquirente ha assicurato ai borghesi il beneficio della vita a buon mercato; ha perseguitato implacabilmente la frode, protetto il lavoratore contro la concorrenza e lo sfruttamento, regolato il suo lavoro e il suo salario, curato la sua igiene, provveduto all'apprendistato, proibito il lavoro della donna e del bambino, ed è riuscita nel medesimo tempo a riservare alla città il monopolio del rifornimento delle campagne circostanti e a consentirle di trovare sbocchi lontani per il suo commercio" (da Le Villes et les Insitutions urbaines au Moyen Âge, tomo I, p. 481). (p. 71)
La monarchia
[...] Fino al XVI secolo l'autorità reale è fondata più sulla forza morale che sugli effettivi militari. Tale forza morale ha solidamente assicurato la fama dei re giustizieri. I Regrets de la mort de Saint Louis [Luigi IX di Francia, conosciuto come il Santo, Poissy, 1214-Tunisi, 1270, fu canonizzato da papa Bonifacio VIII nel 1297. Era il quarto figlio di Luigi VIII e di Bianca di Castiglia, n.d.r.] insistono su questo punto: "Dico che il Diritto è morto / e che la lealtà si è spenta / quando è morto il buon re, / la creatura santa che a ognuna e a ognuno / rendeva giustizia per la sua richiesta. / A chi potranno mai i miseri / appellarsi ora che è morto il buon re / che tanto seppe amarli?" Lo stesso "buon re" ritorna d'altronde spesso su questo punto nei suoi insegnamenti al figlio "Per essere giusto e onesto sii leale e schietto coi tuoi sudditi, senza piegare né a destra né a sinistra, ma sempre dritto e difendi la ragione del povero finché non sia raggiunta la verità".(pp. 75-76)
I rapporti internazionali
[...] Tuttavia, si constata che questa Europa così diversa e travagliata alla sua nascita, vivrà nel XII e XIII secolo un periodo di intesa e di unione che non aveva mai conosciuto prima e che forse non conoscerà più nel corso dei secoli. Nella prima Crociata si vedono principi sacrificare beni e interessi, dimenticare le proprie contese per prendere insieme il simbolo della croce, i popoli più diversi unirsi in una sola armata [...] si vedono monarchi preferire l'arbitrato alla guerra, rimettersi al giudizio del Papa o di un re straniero per dirimere i propri dissensi. Ci si trova davanti, ancora più notevole, un'Europa organizzata; non è un impero e non è nemmeno una federazione, è la Cristianità. [...] (p. 82)
[parlando della guerra]
[...] In seguito vi fu la Tregua di Dio, inaugurata dall'inizio dell'XI secolo anch'essa dall'imperatore Enrico II, dal re di Francia Roberto il Pio e dal papa Benedetto VIII. I concili di Perpignano (1041) e di Elne (1059) l'avevano già riportata in auge quando, nel suo passaggio da Clermont (1095) Urbano II la definisce e la proclama solennemente, nel corso di quel medesimo Concilio che diede origine alle Crociate. Essa limita la guerra nella durata, come la Pace di Dio negli scopi: per volontà della Chiesa ogni atto di guerra è vietato dalla prima domenica di Avvento fino all'ottava dell'Epifania, dal primo giorno di Quaresima fino all'ottava d'Ascensione e, durante tutto il resto dell'anno, dal mercoledì sera al lunedì mattina [...] vi furono anche in questo delle inosservanze, ma a rischio e pericolo del contravventore, anzi, a sua vergogna. [...] (p. 87)
La Chiesa
[...] La donazione di Pipino aveva dato al Papato il dominio territoriale che doveva costituire la base del suo magistero dottrinale; ricevendo la corona dal papa, Carlo Magno affermava insieme il proprio potere e la natura di tale potere, appoggiandosi a a principi spirituali per stabilire l'ordine europeo. Il Papato si dava un corpo e l'impero un'anima. [...] (p. 94)
Alla base della concezione del mondo del Medioevo si scopre semmai un solido ottimismo. A torto o a ragione si parte allora dal principio che il mondo è fatto bene, che se il peccato perde l'uomo, la Redenzione lo salva e che niente, prova o gioia, succede che non sia per il suo bene [...]. "Perché molte volte andando all'avventura, / ciò che si teme, aver pena e dolore, / ha poi l'effetto di dolce nutrimento. / Penso che Dio fa tutto per il meglio. / Dio non ha fatto tutti d'un sol pezzo / né terre e fiori tutti d'un colore / ma nulla accade da cui non possa aprirsi un fiore. / penso che Dio fa tutto per il meglio."
Così si esprime Eustache Deschamps [...] vien da pensare che se vi fu nella storia mondo un'epoca di gioia, questa fu il Medioevo [...] [e] Drieu la Rochelle: "Non a dispetto del cristianesimo, ma per mezzo del cristianesimo si rivela pienamente e apertamente la gioia di vivere, di avere un corpo, un'anima in questo corpo... insomma, la gioia di essere" (Articolo su La conception du corps au Moyen Âge, in Revue Française, n. 1, 1941, p. 16) [...] (pp. 106-107)
L'insegnamento [parlando dei clerici vagantes]
[...] i "chierici vagabondi" (clerici vagantes) o "goliardi", tipi umani essenzialmente medioevali, inseparabili dal clima dell'epoca; tutti "donne e taverne", vanno da un'osteria all'altra, cercando di scroccare un pranzo e soprattutto un bicchiere di vino, frequentando luoghi malfamati, conservano qualche briciola di sapere, di cui si servono per sbalordire i semplici, ai quali recitano versi di Orazio, o frammenti dei poemi cavallereschi; se capita, abbozzano una discussione su qualche questione teologica e finiscono per confondersi nella folla dei giullari [...] le loro canzoni hanno fatto il giro dell'Europa ed il mondo studentesco conosce ancora di questi "canti goliardici": Meum est propositum in taberna mori / vinum sit appositum morientis ori / ut dicant com venerint angelorum chori / Deus sit propitius huic potatori. [...] (p. 114)
HARNONCOURT NIKOLAUS, Il discorso musicale. Scritti su Monteverdi, Bach, Mozart, Jaka Book, Milano 1985.
Per chi non lo conoscesse, Harnoncourt è fra i principali studiosi ed interpreti della musica barocca (basti pensare all'integrale delle Cantate di Bach e all'inarrivabile Vespro della Beata Vergine di Monteverdi), ma ha anche diretto Mozart, Beethoven, fino al Porgy and Bess di Gershwin nel 2010.
Il libro raccoglie - con un tono estremamente semplice e accessibile anche a chi non ha specifiche competenze musicali - una serie di relazioni, conferenze e saggi che il violoncellista e direttore d'orchestra tenne prima del 1984. Di cosa si tratta? Sono riflessioni, a volte in forma di semplici appunti, che mostrano il metodo con cui Harnoncourt affronta il fatto musicale: approfonditi studi critici e storiografici, attenta analisi delle fonti (cioè delle partiture manoscritte), una quasi maniacale ricerca del suono originale che doveva avere "quella" musica quando venne eseguita dal suo autore: " [...] in ogni epoca le possibilità della composizione, della notazione e anche della resa (cioè dello strumentario e della tecnica esecutiva) erano esattamente quelle ideali per la musica corrispondente".
Il libro è colmo di spunti di riflessione per gli amanti della musica, di tutta la musica. Anche per noi cultori del Medioevo esso riserva un capitolo (il primo dopo la Prefazione) intitolato proprio "L'immagine sonora della musica medievale". Cosa ci poteva capitare di meglio?
Purtroppo il volume è oggi disponibile solo nella formula "print on demand": per maggiori informazioni andate sul sito della Casa editrice, o cliccate direttamente su questo link.
(SL)
SACKS OLIVER, Musicofilia. Racconti sulla musica e il cervello, Adelphi, Milano, III ed. 2010.
Tutti noi del Kalòs trascorriamo buona parte delle nostre giornate immersi nella Musica. Già, ma che cos'è la Musica? Ci può aiutare nel trovare una risposta il saggio di Oliver Sacks, medico neurologo, autore anche di “Risvegli”.
Cito, dalla prefazione:
Noi esseri umani, come specie, siamo creature musicali non meno che linguistiche, e questo aspetto della nostra natura assume molte forme diverse. Siamo tutti in grado (con pochissime eccezioni) di percepire gli intervalli, i contorni melodici, l’armonia ed il ritmo. Noi integriamo tutto questo e “costruiamo” mentalmente la musica servendoci di molte parti diverse del cervello. A questo apprezzamento strutturale, in larga misura inconscio, si aggiunge poi una reazione emozionale spesso intensa e profonda. Schopenauer scrisse: “Ciò che nella musica vi è di ineffabilmente intimo, eppur così inspiegabile, sta nel suo riprodurre tutti i moti della nostra più intima natura, ma senza la loro tormentosa realtà”. Prima ancora aveva detto: “… la musica non esprime se non la quintessenza della vita e dei suoi avvenimenti, mai questi stessi”.
(Franco)
JOSEPH RATZINGER, Liturgia e Musica Sacra
Raccomando alla vostra attenzione il discorso tenuto all’Ottavo Congresso Internazionale di Musica Sacra, nel 1985, dall'allora Cardinale Joseph Ratzinger dal titolo "Liturgia e Musica Sacra", del quale riporto qui la conclusione. (SL)
"Vorrei concludere le mie considerazioni con una bella parola di Mahatma Gandhi che ho trovato poco tempo fa su un calendario. Gandhi evidenzia tre spazi di vita del cosmo e mostra come ognuno di questi tre spazi vitali offra anche un proprio modo di essere. Nel mare vivono i pesci e tacciono. Gli animali sulla terra gridano, ma gli uccelli, il cui spazio vitale è il cielo, cantano. Del mare è proprio il tacere, della terra il gridare e del cielo il cantare. L’uomo però partecipa di tutti e tre: egli porta in sé la profondità del mare, il peso della terra e l’altezza del cielo; perciò sono sue anche tutte e tre le proprietà: il tacere, il gridare e il cantare. Oggi vediamo che all’uomo privo di trascendenza rimane solo il gridare, perché vuole essere soltanto terra e cerca di far diventare sua terra anche il cielo e la profondità del mare. La vera liturgia, la liturgia della comunione dei santi, gli restituisce la sua totalità. Gli insegna di nuovo il tacere e il cantare, aprendogli la profondità del mare e insegnandogli a volare, l’essere dell’angelo; elevando il suo cuore fa risuonare di nuovo quel canto che in lui si era come assopito. Anzi, possiamo dire persino che la vera liturgia si riconosce proprio dal fatto che essa ci libera dall’agire comune e ci restituisce la profondità e l’altezza, il silenzio e il canto. La vera liturgia si riconosce dal fatto che è cosmica, non su misura di un gruppo. Essa canta con gli angeli. Essa tace con la profondità dell’universo in attesa. E così essa redime la terra." Joseph Card. Ratzinger
Beowulf è un manoscritto facente parte di un codice miscellaneo conosciuto come Codice Cotton (dall’antiquario inglese Sir Robert Cotton) Vitellius (dalla sistemazione nella sua biblioteca, sotto il busto dell’imperatore romano Vitellio) A XV, conservato ora al British Museum. Il Codice raccoglie cinque testi in prosa e poesia, accomunati dal tema del meraviglioso e del mostruoso: la Vita di un San Cristoforo cinocefalo, le Meraviglie d’Oriente, le Lettere di Alessandro ad Aristotele (che riprendono dalla paradossografia molte storie di prodigi), il Beowulf e il poema di argomento biblico Giuditta, anch’esso, in un certo senso, a soggetto meraviglioso. Questo Poema, anonimo e senza titolo, di datazione incerta (verosimilmente verso la prima decade dell’XI secolo), ha molti primati. È il più antico testo poetico lungo in un volgare europeo, è l’unica epica compiuta delle letterature germaniche antiche, è il testo più importante e più ricco della letteratura anglosassone, e racconta una storia apparentemente semplice: un ragazzo straordinariamente forte si mette per mare con l’idea di andare a sbarazzare la reggia di un altro paese (la Danimarca) infestata da un Orco devastatore ed assassino. Che cosa lo spinge ad attraversare un braccio di mare, non richiesto, male accolto, per andare a trovare in un paese straniero un Orco più straniero ancora? Il viaggio di Beowulf è soprattutto un’esperienza inevitabile di formazione, egli è attratto dall’avventura, dalla forza dell’ignoto. Sarà poi costretto anche a combattere pericolosamente anche con la Madre dell’Orco. Lo stesso Beowulf, diventato vecchio e Re, partirà molto più tardi, sempre solo, per affrontare un Drago di fuoco e strappargli un prodigioso tesoro. Tanto lui che il Drago moriranno nell’impresa ed il tesoro finirà per non servire a nessuno.
Il poema è chiaramente il prodotto di una cultura Cristiana: questo è evidente, per esempio, nell’allusione alla vicenda di Caino e Abele (vv 106-110), e nella distruzione dei giganti nel Diluvio Universale (vv 1688-1693); in entrambi i casi è chiaro che i destinatari del poema erano già conoscitori della Bibbia.
Scritto in antico Inglese, il poema è stato oggetto di svariate traduzioni: tra le principali, quella del poeta nord-Irlandese Séamus Heaney, Premio Nobel per la letteratura nel 1995, recentemente scomparso, e quella di J.R.R. Tolkien, che trarrà dal Poema spunti per i suoi romanzi più famosi: per esempio, il Drago custode di un tesoro immenso è ripreso ne Lo Hobbit (dove è l’acerrimo nemico dei Nani); il mondo degli uomini viene definito middan-geard, “Mondo di Mezzo” (v. 75), che richiama la Terra di Mezzo del Signore degli Anelli.
Bibliografia:
Beowulf, a cura di Ludovica Koch, Einaudi editore, ISBN 88-06-12869-8;
Beowulf - A student Edition edited by George Jack, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-871044-8.
